|
|
Colombo, c'è chi lo vuole
figlio di un Papa
Si tratta del pontefice Innocenzo VIII, genovese,
che lo avrebbe avuto dalla nobildonna romana Anna Colonna
Due studiosi si sono rivolti all'Università di Pavia
chiedendo di cercare il Dna del navigatore
(Il Giornale, Pubblicato Mercoledì 7 Aprile 2004)
 In
questi giorni l'Università di Pavia si è vista recapitare
una nuova richiesta di esami del Dna sui resti di Colombo che conserva in una
teca dell'ateneo. A inoltrarla sono stati due storici romani, Lioniero
Boccianti e Renato Biagioli, i quali (tanto per cambiare) si dicono convinti
di poter dimostrare le origini di Cristoforo Colombo.
In
questi giorni l'Università di Pavia si è vista recapitare
una nuova richiesta di esami del Dna sui resti di Colombo che conserva in una
teca dell'ateneo. A inoltrarla sono stati due storici romani, Lioniero
Boccianti e Renato Biagioli, i quali (tanto per cambiare) si dicono convinti
di poter dimostrare le origini di Cristoforo Colombo.
I due illustri studiosi avanzano l'ipotesi, che per loro è una
certezza, che il grande navigatore non fosse il figlio di Domenico e di Susanna
Fontanarossa, bensì del patrizio Gianbattista Cibo, futuro cardinale
di Genova salito al trono di San Pietro col nome di Innocenzo VIII, e della
nobildonna romana Anna Colonna. Secondo i due romani, il «fattaccio»
sarebbe accaduto nel 1446 tra le discrete mura del Maschio Angioino di Napoli
dove l'allora quattordicenne Cibo avrebbe avuto una relazione con l'affascinante
romana. Quest'ultima, scopertasi incinta, con l'aiuto delle sorelle
si sarebbe trasferita in una città dell'Emilia dove al termine
dei nove mesi avrebbe infine «scodellato» l'intrepido Cristoforo.
A questo punto, non si sa quando né come, il precocissimo Cibo avrebbe
fatto in modo e maniera che il pargoletto fosse affidato a Domenico e Susanna,
in quel di Genova, che l'avrebbero cresciuto come genitori adottivi.
In effetti la favoletta appena raccontata non è neanche nuova in quanto,
prima del duo Boccianti-Biagioli l'aveva presentata il giornalista Ruggero
Marino in un suo libro. E infatti pare che quest'ultimo abbia intrapreso
un'azione legale contro i concittadini per tutelare la sua progenitura.
Ci sarebbe però da chiedersi com'è che un quattordicenne,
e cioè poco più di un bambino, possa mai intrattenere una relazione
con una donna nel fiore degli anni. E com'è che poi possa avere
avuto la disponibilità e il potere di aggiustare le cose in quel modo.
Ma è noto a tutti che quando uno storico si mette un'idea in testa
non ha importanza la realtà dei fatti, quanto il modo per farla passare
come tale. Anche se il risultato è per lo meno inverosimile, come appunto
in questo caso.
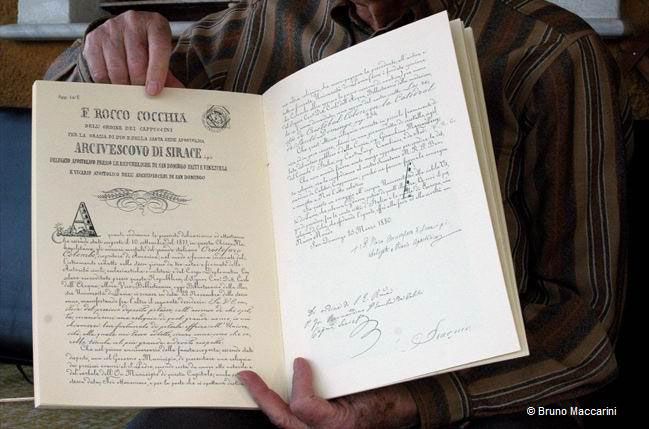 A
parte questi risvolti boccacceschi, quello che comincia a incuriosire molti
lettori sono proprio le novità che in questo periodo stanno emergendo
su Colombo. Molte di queste notizie gli studiosi accademici le conoscono da
tempo, ma il grande pubblico no. E visto che tra il mondo universitario e la
pubblica opinione c'è sempre stato un gap di comunicazione, forse
sarebbe bene cercare di spiegare alcuni di questi aspetti un po' inconsueti.
Per esempio, perché si fa tanto parlare dell'Università
di Pavia? Che cosa c'entra la città lombarda con Colombo?
A
parte questi risvolti boccacceschi, quello che comincia a incuriosire molti
lettori sono proprio le novità che in questo periodo stanno emergendo
su Colombo. Molte di queste notizie gli studiosi accademici le conoscono da
tempo, ma il grande pubblico no. E visto che tra il mondo universitario e la
pubblica opinione c'è sempre stato un gap di comunicazione, forse
sarebbe bene cercare di spiegare alcuni di questi aspetti un po' inconsueti.
Per esempio, perché si fa tanto parlare dell'Università
di Pavia? Che cosa c'entra la città lombarda con Colombo?
Per cercare di rispondere bisogna fare un salto indietro di 127 anni e cioè
risalire alla calda mattina del 10 settembre 1877 quando nella chiesa metropolitana
di Santo Domingo alcuni muratori trovarono una cassa metallica con i resti del
grande navigatore. Alla presenza dell'Arcivescovo di Sirace, monsignor
Rocco Cocchia, delegato apostolico presso le repubbliche di Santo Domingo, Haiti
e Venezuela, vennero dunque allestite tre ampolline di vetro dove vennero sistemate
le ceneri di Colombo, nella misura di circa un cucchiaino per ampolla. Ognuna
di queste era destinata rispettivamente al Pontefice, alla città di Genova
e all'Università di Pavia «dove è fondata opinione
che Colombo abbia appreso le prime notizie di Nautica».
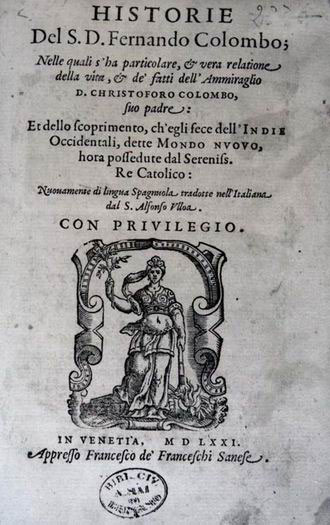 Queste
ampolline partiranno da Santo Domingo soltanto tre anni dopo, esattamente il
25 marzo del 1880, con un attestato firmato dallo stesso Arcivescovo Cocchia
con i sigilli del notaio Joaquin Maria Perez e del console italiano a Santo
Domingo, Luigi Cambiaso. In effetti, però, ci fu una quarta ampollina
e se la riempì per i fatti suoi lo stesso Cambiaso che la affidò
al fratello, ammiraglio luan Battista Cambiaso, perché il «ricordo»
restasse in famiglia. Quest'ampollina con i resti di Colombo è
ancora oggi gelosamente conservata in casa di un gentiluomo genovese.
Queste
ampolline partiranno da Santo Domingo soltanto tre anni dopo, esattamente il
25 marzo del 1880, con un attestato firmato dallo stesso Arcivescovo Cocchia
con i sigilli del notaio Joaquin Maria Perez e del console italiano a Santo
Domingo, Luigi Cambiaso. In effetti, però, ci fu una quarta ampollina
e se la riempì per i fatti suoi lo stesso Cambiaso che la affidò
al fratello, ammiraglio luan Battista Cambiaso, perché il «ricordo»
restasse in famiglia. Quest'ampollina con i resti di Colombo è
ancora oggi gelosamente conservata in casa di un gentiluomo genovese.
Tornando invece a Pavia, c'è da dire che molti studiosi genovesi
non hanno mai digerito il fatto che Colombo possa aver studiato proprio nella
città lombarda. D'altra parte, però, a rivelarcelo è
Io stesso Fernando Colombo nel capitolo III del suo libro «Historie»
pubblicato nel 1521 e, contemporaneamente, Bartolomeo Las Casas, amico personale
dello stesso scopritore, a pagina 46 del volume I del suo «Historia».
Perché mai questi due personaggi avrebbero dovuto mentire? Infatti agli
inizi del 1800 venne istituita una commissione presieduta dall'allora
rettore magnifico dell'Università di Genova, Gerolamo Serra, proprio
per rispondere alla domanda: Colombo studiò a Pavia? La commissione rispose
di sì senza alcun dubbio, ma gli studiosi del secolo dopo misero di nuovo
in discussione questa affermazione.
Perché lo fecero? Perché, pur essendo ormai certo che Colombo
era comunque un genovese, la circostanza di Pavia rivelava soprattutto una cosa:
che Domenico, il padre di Cristoforo, non poteva essere quel povero Ianaiolo
che la tradizione ci ha tramandato. Chi era allora Domenico Colombo? E come
poteva permettersi di mandare il figlio a studiare allo «Studium Ticinense»,
come si chiamava allora l'Università di Pavia?
A questo punto si sovverte l'intera storia di Cristoforo, così
come la conosciamo. Forse, allora, bisognerà prendere in considerazione
la possibilità che la famiglia del navigatore venisse davvero da Cuccaro
Monferrato, dove era feudataria per conto dei Marchesi del Monferrato, e da
dove venne scacciata dall'invasione dei Visconti di Milano. Se Domenico
fosse stato davvero un nobile decaduto, e comunque un faccendiere legato alla
potente famiglia genovese dei Fregoso, allora si spiegherebbero tante cose.
Prima fra tutti l'istruzione elevata di Cristoforo, poi il fatto che si
fosse fatto le ossa in mare navigando agli ordini di un parente, suo omonimo,
che aveva il grado di ammiraglio di Francia, come egli stesso racconta nelle
sue memorie. Ci si spiegherebbe anche perché avesse avuto contatti diretti
con le nobiltà genovese, romana (Papa compreso), spagnola e portoghese.
Diventerebbe anche chiaro perché a Lisbona sposò la nobildonna
Filippa Munoz Perestrello, della famiglia patrizia portoghese di origine piacentina.
Un povero marinaio, come allora era Colombo, avrebbe mai potuto fare un matrimonio
di questo genere?
Insomma gli interrogativi sono e restano tanti. Piuttosto aspettiamoci a breve
un'altra puntata di questa storia infinita perché tra poco il professor
José Lorente dell'Università di Granada annuncerà
i primi risultati delle sue ricerche sul Dna di Colombo. Una nuova polemica
italo-spagnola sta già per scoppiare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Articoli ed eventi correlati:
- Vogliono scipparci Cristoforo Colombo (Dicembre 2002)
- "I resti di Colombo? In un'ampolla a casa mia" (13 Gennaio 2004)
- Cuccaro rivendica il "suo" Colombo (16 Marzo 2004)
- Quella volta che Colombo regalò un'indigena a Michele da Cuneo (5 Gennaio 2006)
- Tramontata nel 2009 l'ipotesi di Colombo proveniente da Cuccaro nel Monferrato (7 Ottobre 2011)
- Una pergamena del ’400 rivela: “Colombo è nato ad Arenzano” (12 Ottobre 2016)
I miei libri | I miei articoli | Eventi & News | Rubrica Letteraria | Multimedia
Documenti | Facebook | X | YouTube | Instagram | Contatti
© 2001-2025 Rino Di Stefano – Vietata la riproduzione, anche parziale, senza esplicita autorizzazione
Informativa sul Copyright – Informativa sulla Privacy






